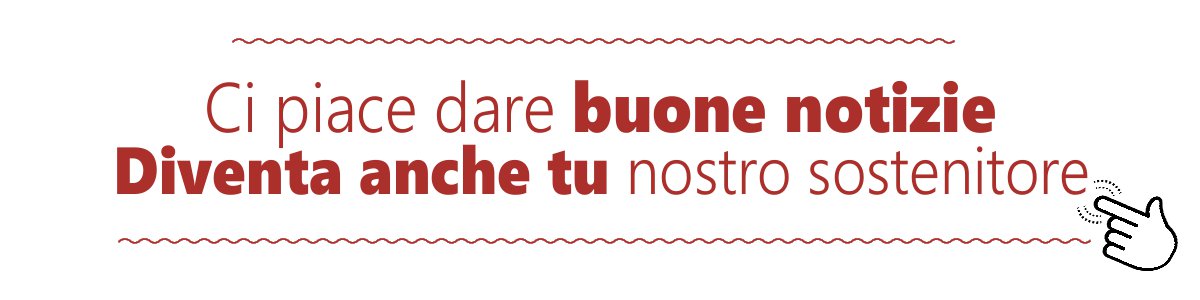Da 120 anni il Santo custodisce il più grande organo italiano
Seimila canne, 162 registri, cinque casse espressive: lo strumento progettato da Carlo Vegetti Bossi unificava in un unico strumento i quattro precedenti. Alberto Sabatini ricostruisce 800 anni di storia organaria della basilica, scaturita dall’attenzione che da subito i francescani dedicarono a questo strumento.

Ha 120 anni, ma il fiato non gli manca. Dopo l’intervento curato dalla ditta Mascioni quattro anni fa, l’organo plurifonico della basilica del Santo, uno dei più grandi d’Italia con i suoi sei distinti corpi, due consolle (una da cinque e una da tre tastiere), cinque casse espressive e 162 registri che comandano più di seimila canne, dispiega a ogni solennità la sua voce potente e armonica, a lode del Signore.
Quello inaugurato il 14 dicembre del 1895 è l’ultimo di una lunga serie di strumenti, la cui storia viene raccontata da Alberto Sabatini, l’organologo che ha seguito l’ultimo intervento: un organista, concertista, didatta, compositore, tra i più noti e quotati studiosi italiani d’arte organaria, a cui si deve un paziente e competente impegno di traduzione e divulgazione d’antiche opere didattiche e teoriche per rivalutare strumenti musicali come l’harmonium e l’organo antico. «Già da alcuni lustri – commenta Sabatini a questo proposito – strumenti antichi come l’organo e l’harmonium hanno iniziato a destare l’interesse degli studiosi.
Straordinariamente complesso, genialmente costruito, impareggiabilmente abile a produrre innumerevoli timbri e sonorità, l’organo compendia gli strumenti di un’intera orchestra. È dunque necessario rivalutarlo con mezzi di divulgazione che ne esaltino le qualità culturali e, soprattutto, cultuali. Ogni organo, “documento sonoro” vivo, è custode della memoria storica di una collettività, testimone delle vicende vissute da una comunità di fedeli ed è il miglior cantore di un’assemblea che prega il suo Dio. Scandisce i vari momenti liturgici vissuti durante l’anno liturgico o nella vita personale; è, poi, anche un orator d’inestimabile valore il quale, al di là dei confini linguistici, culturali e sociali che talvolta possono rappresentare un’invalicabile barriera per le relazioni umane, riesce a parlare – quasi mediante una lingua sovranazionale – a ogni cuore di buona volontà». Una memoria liturgico-artistica che la basilica del Santo tiene viva da ottocento anni, come si scopre dal libro di Sabatini, Gli organi della Pontificia basilica del Santo a Padova. Ottocento anni di storia e arte organaria nell’insigne santuario antoniano (pp. 174, euro 68,00) in uscita per i tipi di Armelin musica. «È molto probabile – sottolinea l’autore spiegando gli 800 anni citati nel titolo – che il Santo sia stato dotato sin dagli inizi di uno o più organi a canne per l’assistenza alle solenni liturgie: gli ordini mendicanti, in special modo i francescani, si mostrarono sempre favorevoli verso questo tipo di strumento in netta contrapposizione alle comunità monastiche o canonicali».
Il primo documento che fa riferimento all’organo della basilica risale al 27 dicembre 1487, quando la Veneranda Arca del Santo istituiva la cappella musicale e statuiva non solo di reperire un eccellente organista e un capace maestro di musica, ma anche di trovare un provetto artefice organario. Tra il 1440 e il 1442 l’organaro teutonico Giorgio d’Alemagna aveva eretto per questa basilica ben due organi: uno piccolo e uno grande. Nel 1489 i massari dell’Arca decretarono di collocare questi due strumenti sulle facce dei due pilieri prospicenti la navata centrale che sorreggono la volta della cupola del presbiterio e la cupola della lanterna, detta “dell’Angelo”. In quello stesso anno il veneziano Antonio Dilmani, per 250 ducati d’oro, si obbligava a costruire un ulteriore nuovo strumento e nel 1538 i massari dell’Arca trattarono con Vincenzo Colombi la costruzione di un quarto organo «di cinquanta tasti e dieci registri della stessa bontà di quello più piccolo della chiesa di San Marco in Venezia» che sarebbe stato collocato tra i due pilastroni verso l’arca del santo. Nel Seicento, in conformità al mutato spirito dell’epoca, sull’esempio di altre antiche chiese si decise di rimuovere il coro dalla originaria posizione davanti al presbiterio per trasportarlo, diviso in due sezioni, in fondo all’abside, rendendo così visibile dalla navata centrale tutto il presbiterio e l’altare maggiore. In tale occasione furono riposizionati i due organi vecchi sui pilastroni dell’imboccatura del nuovo coro e i due più piccoli, detti anche “da concerto”, furono addossati ai grandi pilieri ai lati del presbiterio, verso la navata centrale. In basso invece, tutt’intorno, gli spazi fra i pilastri sarebbero stati riempiti – come pure gli intercolumni dell’abside – con murature rivestite di ricchissimi marmi facendo correre al di sopra, come si vede ancora oggi, una ricca cantoria con parapetti in marmo traforato, sulla quale dovevano poggiare i quattro organi; qui, nelle solennità, prendevano posto maestri, cantori e suonatori della cappella, tutti vestiti in toga e cotta bianca. Tale uso, rimasto fino al 1895, dava all’insieme un grandioso effetto scenico.
Essendo ormai gli strumenti logorati dall’uso continuo, nonostante i restauri, il 30 dicembre 1743 la presidenza dell’Arca affidò al più celebre organaro veneziano, don Pietro Nacchini, di origini dalmatine, il rifacimento di tutti e quattro gli organi. Egli installò tre dei quattro suoi nuovi strumenti tra il 1745 e 1746 e nel gennaio 1749 consegnò l’ultimo, senza però montarlo. Un grave incendio, scoppiato in basilica all’inizio di quell’anno, oltre a distruggere il coro ligneo e quattro delle otto cupole, rovinò irrimediabilmente uno degli strumenti nacchiniani rendendone inoperosi altri due; l’organaro dovette risistemare tutti gli organi rovinati dall’infausto evento. Il catino absidale nella sua veste prevalentemente barocca, in cui primeggiavano i quattro organi, rimase tale sino alle soglie del settimo centenario dalla nascita di sant’Antonio nel 1895. Per rendere maggiormente solenne e far ricordare in forma duratura tale data, l’Arca promosse la desiderata riforma della cappella musicale Antoniana secondo i criteri artistici della restaurazione della musica sacra; si diede il via a una serie di iniziative architettoniche, tra cui spicca il grandioso ripristino dell’interno del tempio, soprattutto nell’area presbiteriale, per opera dell’architetto Camillo Boito.
Tra i più ambiziosi progetti vi fu la realizzazione di un nuovo e grandioso organo; indetto un concorso fra alcune delle più rinomate fabbriche d’organi dell’epoca, la commissione preposta scelse il progetto di Carlo Vegezzi Bossi di Torino che prevedeva la costruzione del più grande organo esistente allora in Italia. La commissione conservatrice dei monumenti di Padova, dopo non poche discussioni, deliberò di collocarlo sopra la cappella di San Giacomo. È questa l’opera, provvista di tutti i più moderni ritrovati tecnici e artistici dell’epoca, che fu inaugurata il 14-15 dicembre 1895 con memorabili concerti di Marco Enrico Bossi, Filippo Capocci e Luigi Bottazzo. I quattro organi vecchi vennero smantellati; le casse armoniche lignee vendute: due oggi si trovano nel duomo di Piove di Sacco.