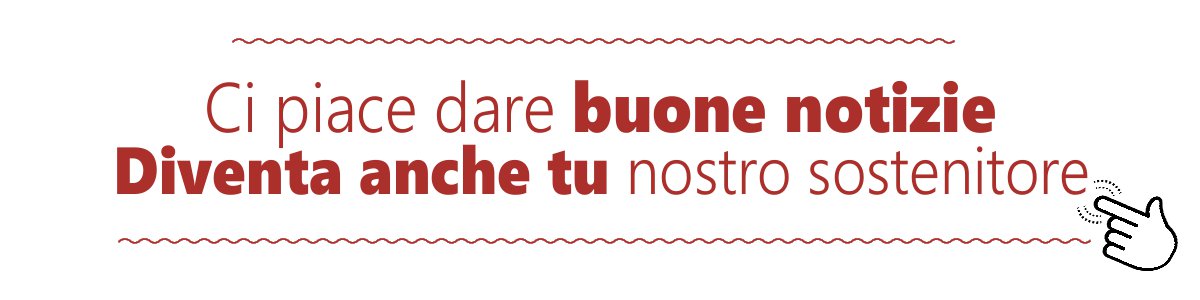Il papa in Messico, un grande abbraccio di bene
Le parole dell'inviato del Sir e del Tg1 al seguito di papa Francesco nell'ultimo viaggio in Messico ripercorrono i momenti più significativi di una settimana in cui il primo papa sudamericano ha ancora una volta rivolto il suo sguardo ai poveri e agli ultimi e tra quasi agli indios , a cui ha chiesto perdono; ai giovani, a cui ha ripetutamente chiesto di non smettere di sognare; ai migranti di Ciudad Juarez che rischiano tutto per una nuova vita negli Stati Uniti.

Papa Francesco in silenziosa preghiera davanti la Morenita, la Madonna di Guadalupe, è sicuramente l’immagine simbolo di questo viaggio in Messico, ferito dalla corruzione, dalla violenza, dal narcotraffico, metastasi che divora. È un papa che consegna alla madre di Dio sofferenze e lacrime del popolo messicano, perché nella costruzione del “santuario della vita” nessuno può essere lasciato fuori e tutti siamo necessari, specialmente quelli che non contano perché non sono all’altezza delle circostanze.
Il santuario di Dio, dice Francesco nell’omelia guadalupana, «è la vita dei suoi figli, di tutti e in tutte le condizioni, in particolare dei giovani senza futuro esposti a una infinità di situazioni dolorose, a rischio, e quella degli anziani senza riconoscimento, dimenticati in tanti angoli». Santuario di Dio sono le famiglie «che hanno bisogno del minimo necessario per potersi formare e sostenere», ed è «il volto di tanti che incontriamo nel nostro cammino».
La guarda a lungo, in silenzio, con calma, seduto nel Camarin, la piccola sala dietro l’icona mariana. Le chiede di accompagnare tante vite, asciugare tante lacrime. Ricordando l’apparizione all’indio Juan Diego, afferma che Dio «ha risvegliato e risveglia la speranza dei più poveri, dei piccoli, dei sofferenti, degli sfollati e degli emarginati, di tutti coloro che sentono di non avere un posto degno in queste terre».
È una preghiera di speranza per questo popolo, «dove non ci sia bisogno di emigrare per sognare; dove non ci sia bisogno di essere sfruttato per lavorare; dove non ci sia bisogno di fare della disperazione e della povertà di molti l’opportunismo di pochi. Una terra – dice all’Angelus a Ecatepec, la città delle donne scomparse e uccise – che non debba piangere uomini e donne, giovani e bambini che finiscono distrutti nelle mani dei trafficanti della morte».
Francesco guarda a una chiesa capace di uscire, di stare accanto a chi soffre, è in difficoltà; una chiesa che non si rifugia in condanne generiche, ma che si muove con coraggio profetico «avvicinando e abbracciando la periferia umana ed esistenziale dei territori desolati delle nostre città». Una chiesa che coinvolge comunità parrocchiali, scuole, istituzioni, politica: «Solo così si potrà liberare totalmente dalle acque in cui purtroppo annegano tante vite, sia quella di chi muore come vittima, sia quella di chi davanti a Dio avrà sempre le mani macchiate di sangue, per quanto abbia il portafoglio pieno di denaro sporco e la coscienza anestetizzata». Solo una chiesa «capace di proteggere il volto degli uomini che vanno a bussare alla sua porta è capace di parlare loro di Dio. Se non decifriamo le loro sofferenze, se non ci accorgiamo dei loro bisogni, nulla potremmo offrire».
In Chiapas
2.200 metri di altitudine, tra boschi, valli e montagne che si stagliano all’orizzonte. È il Chiapas, stato povero all’estremo sud-est del Messico, terra di indigeni e porta di ingresso di migranti sudamericani. I vinti senza storia. Si potrebbero chiamare così i popoli indigeni, con le loro culture e tradizioni; popoli dimenticati sconfitti, disprezzati, esclusi. La tappa di papa Francesco a San Cristobal de las Casas richiama alla mente la storia dei rapporti, spesso conflittuali, tra la chiesa e le popolazioni aborigene. E per questo il papa chiede perdono a questi uomini e donne, perdono perché le loro tradizioni e culture sono state non di rado massacrate.
«Abbiamo ancora molto da imparare – dice il papa nella sua omelia a San Cristobal de las Casas – da queste popolazioni che amano la natura e considerano la terra non come un bene da possedere, ma un dono di Dio e degli antenati».
Con i giovani
Gli incontri con i giovani sono sempre una festa fatta di gioia e colori. La coreografia non è soltanto sui palchi ma anche sugli spalti dello stadio: croci, bandiere e delle grandi ali di farfalle accompagnano i canti e l’allegria di questi giovani.
Un grande striscione scende lentamente quasi a coprire l’intera curva; c’è una colomba bianca, lo Spirito santo, su uno sfondo che progressivamente diventa sempre più blu.
Anche questo è un messaggio di speranza, con il papa che raccomanda ai giovani di non perdere la speranza, di non smettere di avere l’incanto di sognare e di non fermarsi di fronte alle difficoltà ma di reagire: il trionfo, dice loro, non consiste nel non cadere ma nel non rimanere caduti.
L’invito è, dunque, a non lasciarsi escludere, disprezzare, trattare come merce. Non è vero che l’unico modo di vivere, di essere giovani è lasciare la vita nelle mani del narcotraffico o di tutti quelli che la sola cosa che fanno è seminare distruzione e morte.
Nel cielo salgono migliaia di palloncini bianchi e gialli, le croci, è la missione giovani, vanno a inserirsi in un palco posto al centro del campo di calcio mentre lentamente una grande croce, coperta da un telo giallo, si scopre e si alza verso il cielo. Anche in questa coreografia c’è un messaggio che ai giovani non è sicuramente sfuggito: certo