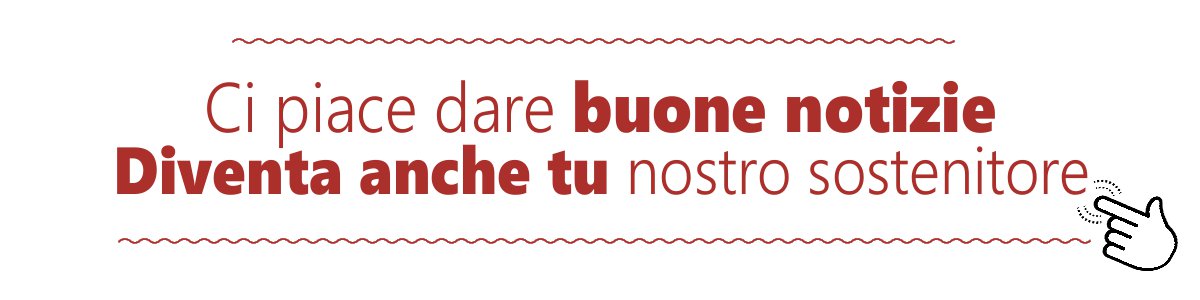Genesi come scuola di vita. Un libro della scrittrice Marilynne Robinson
In “Leggere Genesi” è giustamente importante la valutazione umana, politica ed economica al di là della effettiva storicità di eventi e personaggi

“Leggere Genesi” della grande scrittrice americana Marilynne Robinson (Marietti1820, 288 pagine, 18,05 euro; trad. di L. Scarmoncin, F. Cosi, A. Repossi) è qualcosa di più e di diverso da una esegesi biblica: piuttosto un colpo d’occhio a noi contemporaneo, e con la consapevolezza di questa prospettiva temporale, sul primo libro della Bibbia, attraverso la prova provata di quella che è chiamata eterogenesi dei fini, vale a dire uno sviluppo delle azioni umane che va diversamente da quanto è stato stabilito all’inizio.
Nel contempo è possibile trovare qui anche quella lenta strada di differenziazione della concezione di Dio da parte di Israele, partendo dalle sue origini pastorali e nomadi. Un elemento umano, ancorato al senso di giustizia, emerge spesso da “Leggere Genesi”: ad esempio quando, parlando della rovina di Sodoma e Gomorra, la scrittrice non si sofferma solo sui peccati di lussuria e dismisura, ma anche sulla inospitalità e sulla violenza contro gli stranieri, dimensione che rende ancor più attuale buona parte del messaggio biblico, a patto che lo si legga con la consapevolezza del mutare delle ideologie, delle tecniche narrative e della loro trasmissione.
Robinson reca un messaggio dal duplice significato: da una parte il comportamento umano ha la sua rilevanza nelle pagine di Genesi, dall’altra le vie divine sconvolgono e ricompongono quegli eventi in modi che non sempre sono riducibili alla nostra ragione, se non quando, come fa la scrittrice, si ritorna a Sodoma e Gomorra cui il Signore manda un altro messaggio preciso: non hanno senso i sacrifici di innocenti animali, perché essi non solo sopprimono esistenze, ma sviano dalla vera causa della rovina di quelle città, che è nel comportamento e nelle scelte degli abitanti.
Anche perché in “Leggere Genesi” è giustamente importante la valutazione umana, politica ed economica al di là della effettiva storicità di eventi e personaggi. L’insegnamento è, soprattutto nelle importanti pagine che Robinson dedica a Giuseppe e i suoi fratelli (su cui, tra l’altro, Thomas Mann ha scritto un importante ciclo di romanzi), che la volontà di Dio va oltre le usanze e i costumi del tempo e si inserisce in un progetto più vasto: ad esempio quello del rifiuto della vendetta.
E questo è un fondamentale elemento di separazione dalle altre narrazioni antiche, ad esempio quella dell’Odissea in cui Ulisse si vendica dei Proci che avevano invaso la sua casa, tentando di approfittare della amata Penelope: “il Signore non è la Nemesi. È libero, agisce per i Suoi fini, indifferente alla spietata simmetria della vendetta”.
Dio, fa notare l’autrice, sceglie i suoi protagonisti non in base ai calcoli umani fatti di appartenenza sociale, ricchezza, prestigio, ma attraverso quello che qui viene chiamato un suo proprio “umanesimo”: sceglie servi, umili vedove, schiavi, pastori nomadi in un rovesciamento radicale delle categorie epiche che vigevano nelle civiltà di allora, da quella egizia alla greca alla persiana.
Anche qui sta la portata rivoluzionaria del monoteismo, che inizia a farsi strada all’interno di religioni politeistiche nelle quali le divinità avevano pregi ma anche capricci e reazioni umane, come la vendetta, la lussuria, la tracotanza.
Ed è proprio questo il centro focale del libro: il passaggio da una visione del tutto umana delle divinità all’accettazione che il corso degli eventi è sorprendente ma non in balìa del caos, con la messa in rilievo del Bene di cui parlano Proverbi e san Paolo, perché, conclude Robinson, “Se ci vogliamo allineare alla volontà di Dio, accogliere ogni difficoltà, grazia, gentilezza è chiaramente la scelta più sicura”.